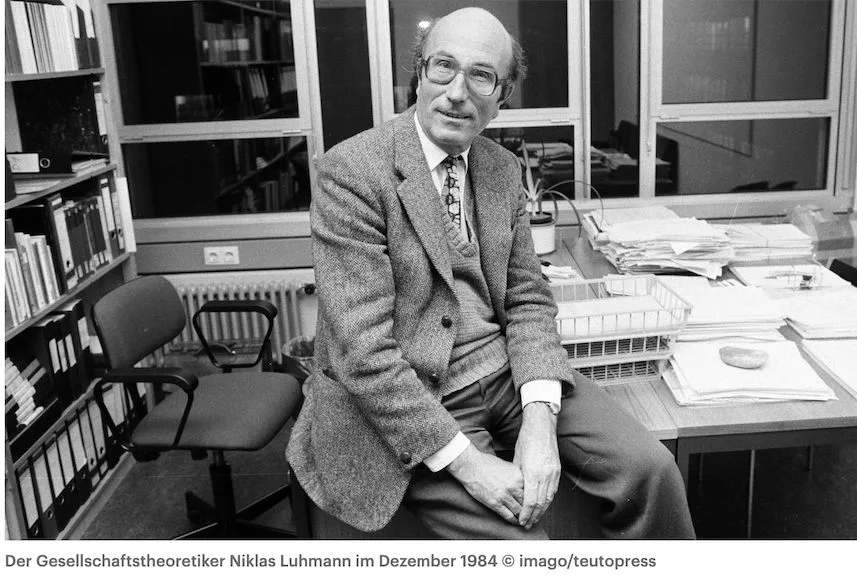 (s.m.) Tutto meno che sinodale. Questa è l’immagine che la Chiesa sta dando di sé, dopo quattro settimane di dibattito a porte chiuse fra 365 vescovi e non vescovi, di “conversazioni nello Spirito” consegnate a una relazione finale tanto enciclopedica quanto elusiva, ma con papa Francesco che nel frattempo ha provveduto lui, in pieno assolutismo monarchico, a pubblicare le sue risposte a una raffica di questioni più di teatro che di sostanza, su conviventi, omosessuali, transessuali alle prese con comunioni, battesimi, matrimoni e padrinati vari.
(s.m.) Tutto meno che sinodale. Questa è l’immagine che la Chiesa sta dando di sé, dopo quattro settimane di dibattito a porte chiuse fra 365 vescovi e non vescovi, di “conversazioni nello Spirito” consegnate a una relazione finale tanto enciclopedica quanto elusiva, ma con papa Francesco che nel frattempo ha provveduto lui, in pieno assolutismo monarchico, a pubblicare le sue risposte a una raffica di questioni più di teatro che di sostanza, su conviventi, omosessuali, transessuali alle prese con comunioni, battesimi, matrimoni e padrinati vari.
Ma più ancora è l’immagine di una Chiesa che perde di vista l’essenziale, cioè quella prossimità con Dio che è il cuore del “Credo” cristiano. E questo proprio mentre tra gli uomini la fede si affievolisce e si spegne, e Dio stesso svanisce, anche in quelle che si credevano cattolicità fiorenti.
Ciò che colpisce è che a richiamare da tempo la Chiesa a questa priorità assoluta non s’è levata soltanto la voce di un Joseph Ratzinger teologo e papa, ma anche quella – per vie originalissime – di un non credente come il suo connazionale Niklas Luhmann (1927–1998), uno dei pensatori più importanti e controversi della seconda metà del Novecento.
Di Luhmann ricorre il venticinquesimo anniversario della morte. E proprio in questi giorni è uscito in Italia un suo nitido profilo nella collana Classici contemporanei di IBL Libri, a firma di uno dei suoi più attenti studiosi, Sergio Belardinelli, professore di sociologia dei processi culturali all’Università di Bologna e dal 2008 al 2013 coordinatore scientifico del Comitato per il progetto culturale della conferenza episcopale italiana.
Per Luhmann politica, economia, arte, scienza, religione, mass media e tanti altri campi vanno considerati come sistemi sociali autonomi, ciascuno specializzato nella risoluzione di un determinato ordine di problemi, in una società sempre più complessa come l’attuale.
E per la religione la funzione specifica è di comunicare apertura alla trascendenza, a quel Dio che aiuta a capire che tutto è contingente, e quindi a contrastare qualsiasi forma di fondamentalismo, di moralismo e di politica che pieghi la religione al proprio servizio. Una religione in cui “tutto dipende dalla fede”, non certo una sorta di agenzia di solidarietà sociale contro le storture del mercato capitalistico, come oggi anche la Chiesa cattolica è tentata d’essere.
È questo che Luhmann scrive e argomenta in un suo saggio anch’esso uscito per la prima volta quest’anno in edizione italiana, per i tipi di Franco Angeli: “La religione della società”.
Al professor Belardinelli la parola, per illustrare il pensiero di questo suo grande maestro, di sorprendente attualità per la Chiesa d’oggi.
*
PER UN CRISTIANESIMO IN CUI “TUTTO DIPENDE DALLA FEDE”
di Sergio Belardinelli
È quanto meno sorprendente che qualcuno parli di religione guardando non tanto al mistero, al mito, al sacro, ai riti, al guazzabuglio del cuore umano, bensì a una forma di comunicazione, la comunicazione religiosa, la quale avrebbe a che fare principalmente con l’irrappresentabilità del mondo, in quanto orizzonte ultimo del senso nel suo insieme, e il cui codice specifico sarebbe “trascendenza/immanenza”.
Ma questo è esattamente ciò che ha fatto Niklas Luhmann, secondo il quale la funzione sociale della religione sarebbe molto semplicemente quella di tenere aperta la comunicazione anche su ciò che ordinariamente oltrepassa i suoi confini.
Alla larga dunque dall’idea che nella società moderna la religione abbia patito una perdita di funzione. “La tesi della perdita di funzione – egli scrive in ‘La religione della società’ – dà per scontato che la religione svolga molte funzioni, delle quali alcune le sono state tolte”. Se invece, come sostiene Luhmann, la religione svolge la sola funzione comunicativa indicata sopra, allora non soltanto non si potrebbe parlare di perdita di funzione, ma si dovrebbe addirittura “fare i conti con la possibilità che, ritirandosi da molti altri ambiti funzionali, rinunciando al ‘social control’ e alla legittimazione del potere politico, le ‘chance’ della religione crescano”.
Questo non significa, per Luhmann, che si debba registrare un “revival” di condotte di vita determinate dalla religione, né che la fede in Dio o la distinzione tra sacro e profano, cosi cara alla sociologia classica – vedi Durkheim e Simmel – tornino in auge. Piuttosto esse si dissolvono. Restano invece la funzione e il codice della religione quali criteri di riconoscimento del sistema religioso e dei suoi confini.
Non ogni stravaganza può essere insomma considerata religione, e se certamente lo spazio che secondo Luhmann resta alla religione non è quello che solitamente si attribuiscono le religioni stesse, è pur vero che basta uno sguardo a trascendenza/immanenza come codice del sistema religioso, per comprendere quanto la posizione luhmanniana potrebbe essere utile proprio a una religione che voglia essere all’altezza del tempo nel quale è chiamata ad operare.
Lo stesso si potrebbe dire di Dio, considerato da Luhmann una semplice “formula di contingenza”. Nessun teologo forse lo accetterebbe, ma in termini sistemici questo Dio rappresenta il modo piuttosto audace col quale la religione giustifica la contingenza del mondo e la perfezione di un essere che è totalmente trascendente ma anche in tutte le cose, le quali proprio per questo potrebbero stare diversamente da come stanno, mostrando così la loro costitutiva contingenza.
Possiamo certamente concordare sul fatto che questo modo di parlare di Dio sia piuttosto insolito; colpisce tuttavia quanto esso sia intellettualmente stimolante proprio per coloro che considerano ancora la questione di Dio una questione seria.
In una società secolarizzata, dove i sistemi sociali si specializzano ciascuno secondo la propria funzione, Dio potrebbe aiutare a comprendere la contingenza di tutto ciò che è e accade, quindi a contrastare qualsiasi forma di fondamentalismo, di moralismo e di politica che usi la religione magari al servizio di una società più coesa.
Ma affinché questo Dio si renda in qualche modo presente nella società, c’è bisogno soprattutto di fede. Proprio come dice Luhmannn, la formulazione più efficace di una religione mondiale come il cristianesimo “potrebbe essere che in materia di religione tutto dipende dalla fede”.
È la fede il vero “medium” religioso di una religione mondiale come il cristianesimo. La quale fede, depurata delle sue codificazioni morali, politiche, confessionali, e concentrata sulla trascendenza, potrebbe proprio per questo ridiventare generatrice di forme di vita rilevanti anche per la società. Per conseguire questo obbiettivo, le Chiese cristiane potrebbero non aver bisogno di impalcature istituzionali troppo potenti, ma certamente hanno bisogno di Dio, della fede e di una chiara consapevolezza della loro propria funzione in un mondo in cui credenti e non credenti debbono anzitutto accettare l’idea di vivere sulla base del loro essere diversi.
Può la teoria sistemica di Niklas Luhmann essere di qualche aiuto in proposito?
Io credo di sì, ma a condizione di non chiederle ciò che non può dare. Detto in altre parole, non bisogna dimenticare che stiamo parlando di una teoria che cerca di “riflettere” ciò che evolutivamente si mostra nello sviluppo della società, di “osservare” dall’esterno i suoi sistemi. La teoria non dice come dovrebbero funzionare i sistemi che osserva. Semplicemente li osserva, esplicitandone codici e funzioni.
Nel caso della religione Luhmann ci dice che il suo codice è trascendenza/immanenza e che la sua funzione è quella di rappresentare ciò che non è rappresentabile, il senso stesso di tutto, anche del non senso, a cominciare dalla morte.
Ebbene, che osservando la religione egli ci dica questo a me pare un contributo importante e sorprendente, specialmente oggi, tentati come siamo di attribuire alla religione le funzioni più diverse, fino a farne una sorta di agenzia di solidarietà sociale contro le storture del mercato capitalistico.
Il modo in cui Luhmann parla della religione potrebbe rappresentare addirittura una sorta di salutare richiamo all’essenziale – cioè appunto a trascendenza/immanenza – e un incoraggiamento per coloro per i quali “la religione significa molto di più di quanto possa dire la teoria”.
La teoria osserva la società, non il cuore degli uomini, che può essere osservato soltanto da Dio. Quanto al sistema religioso, detto in termini sistemici, esso dipende soltanto dalla sua vitalità operativa nella comunicazione religiosa e nell’articolazione religiosa del senso, ossia dalla capacità di assolvere una funzione cruciale per la società.
In termini non sistemici, ma in linea di principio non in contrasto con la teoria sistemica, la religione è chiamata a coltivare soprattutto ciò che la fa essere ciò che è: l’articolazione teorica e pratica di un rapporto con Dio – la trascendenza –, capace di dare un colore diverso agli eventi e alle cose di un mondo che, essendo sempre più variopinto e affollato di forme anche religiose, proprio per questo le spinge alla differenziazione, nel rispetto della propria e dell’altrui diversità.
———-
Sandro Magister è firma storica del settimanale L’Espresso.
Questo è l’attuale indirizzo del suo blog Settimo Cielo, con gli ultimi articoli in lingua italiana: settimocielo.be
Ma di Settimo Cielo è consultabile anche l’intero archivio, anno per anno e in più lingue:
> 2024–2023-2022–2021-2020–2019-2018–2017
Come pure l’indice completo del blog www.chiesa che l’ha preceduto:
> 2016–2015-2014–2013-2012–2011-2010–2009-2008–2007-2006–2005-2004–2003-2002
