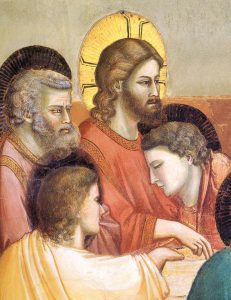 (s.m.) Nel calendario diramato dal Vaticano a fine marzo delle celebrazioni pasquali di quest’anno, mancava del tutto la messa “in coena Domini” della sera del giovedì santo.
(s.m.) Nel calendario diramato dal Vaticano a fine marzo delle celebrazioni pasquali di quest’anno, mancava del tutto la messa “in coena Domini” della sera del giovedì santo.
Da quando Jorge Mario Bergoglio è papa, è sempre avvenuto così. Solo all’ultimo si rendeva noto dove lui avrebbe celebrato, di solito in un carcere. E la notizia riguardava non tanto la messa, ma la lavanda dei piedi che egli avrebbe fatto a dodici carcerati o immigrati, uomini e donne, cristiani, musulmani, con o senza fede.
Anche le omelie tenute in queste circostanze da papa Francesco erano del tutto coerenti con la priorità assoluta data alla lavanda dei piedi. Erano di poche parole, improvvisate, quasi sempre e soltanto ridotte a un’esortazione al perdono e al servizio fraterno.
Alla messa non era fatto abitualmente neppure un cenno. Eppure quella del giovedì santo è un caposaldo della liturgia cristiana, la memoria dell’ultima cena di Gesù con gli apostoli (nell’illustrazione un particolare affrescato da Giotto nel 1303), la prima di tutte le messe di ieri, di oggi e di domani.
Anche quest’anno, con Francesco in precarie condizioni di salute, l’aspettativa generale si è concentrata su chi e dove avrebbe compiuto al suo posto la lavanda dei piedi – con una supplenza che alla fine è stata lasciata cadere – e soprattutto sull’eventuale, fugace comparsa sulla scena del papa in persona, magari con una sua visita al vicino carcere romano di Regina Coeli.
Ma perché invece non riportare alla luce quello che la metamorfosi del giovedì santo compiuta dall’attuale pontefice ha occultato? Perché non ritornare al cuore autentico della messa “in coena Domini”?
Quella che segue è l’omelia tenuta nella messa del giovedì santo del 2008 da papa Benedetto XVI, che sempre la celebrava nella cattedrale di San Giovanni in Laterano.
L’omelia prende spunto dalla pagina del Vangelo di Giovanni che si legge in questa messa, dove al posto del racconto dell’ultima cena c’è appunto quello di Gesù che lava i piedi ai suoi apostoli. Ma ciò che papa Benedetto ne ricava è incomparabile con la superficialità dello spettacolo in voga da anni.
Che l’omiletica sia stata una vetta del pontificato di Joseph Ratzinger è un giudizio condiviso da molti. E Settimo Cielo ne ha già spiegato il perché, nell’introduzione a un libro che per la prima volta nel 2008 raccoglieva un anno di predicazione liturgica di quel papa.
Questa omelia ne è una prova splendente. Buona lettura e buona Pasqua!
*
Omelia della messa “in coena Domini” del 20 marzo 2008
di Benedetto XVI
Cari fratelli e sorelle, san Giovanni inizia il suo racconto su come Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli con un linguaggio particolarmente solenne, quasi liturgico. “Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13, 1).
È arrivata l’“ora” di Gesù, verso la quale il suo operare era diretto fin dall’inizio. Ciò che costituisce il contenuto di questa ora, Giovanni lo descrive con due parole: passaggio (metabainein, metabasis) ed agape, amore. Le due parole si spiegano a vicenda; ambedue descrivono insieme la Pasqua di Gesù: croce e risurrezione, crocifissione come elevazione, come “passaggio” alla gloria di Dio, come un “passare” dal mondo al Padre. Non è come se Gesù, dopo una breve visita nel mondo, ora semplicemente ripartisse e tornasse al Padre. Il passaggio è una trasformazione. Egli porta con sé la sua carne, il suo essere uomo. Sulla Croce, nel donare se stesso, Egli viene come fuso e trasformato in un nuovo modo d’essere, nel quale ora è sempre col Padre e contemporaneamente con gli uomini. Trasforma la Croce, l’atto dell’uccisione, in un atto di donazione, di amore sino alla fine.
Con questa espressione “sino alla fine” Giovanni rimanda in anticipo all’ultima parola di Gesù sulla Croce: tutto è portato a termine, “è compiuto” (Gv 19, 30). Mediante il suo amore la Croce diventa metabasis, trasformazione dell’essere uomo nell’essere partecipe della gloria di Dio. In questa trasformazione Egli coinvolge tutti noi, trascinandoci dentro la forza trasformatrice del suo amore al punto che, nel nostro essere con Lui, la nostra vita diventa “passaggio”, trasformazione. Così riceviamo la redenzione – l’essere partecipi dell’amore eterno, una condizione a cui tendiamo con l’intera nostra esistenza.
Questo processo essenziale dell’ora di Gesù viene rappresentato nella lavanda dei piedi in una specie di profetico atto simbolico.
In essa Gesù evidenzia con un gesto concreto proprio ciò che il grande inno cristologico della Lettera ai Filippesi descrive come il contenuto del mistero di Cristo. Gesù depone le vesti della sua gloria, si cinge col “panno” dell’umanità e si fa schiavo. Lava i piedi sporchi dei discepoli e li rende così capaci di accedere al convito divino al quale Egli li invita.
Al posto delle purificazioni cultuali ed esterne, che purificano l’uomo ritualmente, lasciandolo tuttavia così com’è, subentra il bagno nuovo: Egli ci rende puri mediante la sua parola e il suo amore, mediante il dono di se stesso. “Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato”, dirà ai discepoli nel discorso sulla vite (Gv 15, 3).
Sempre di nuovo ci lava con la sua parola. Sì, se accogliamo le parole di Gesù in atteggiamento di meditazione, di preghiera e di fede, esse sviluppano in noi la loro forza purificatrice. Giorno dopo giorno siamo come ricoperti di sporcizia multiforme, di parole vuote, di pregiudizi, di sapienza ridotta ed alterata; una molteplice semifalsità o falsità aperta s’infiltra continuamente nel nostro intimo. Tutto ciò offusca e contamina la nostra anima, ci minaccia con l’incapacità per la verità e per il bene. Se accogliamo le parole di Gesù col cuore attento, esse si rivelano veri lavaggi, purificazioni dell’anima, dell’uomo interiore.
È, questo, ciò a cui ci invita il Vangelo della lavanda dei piedi: lasciarci sempre di nuovo lavare da quest’acqua pura, lasciarci rendere capaci della comunione conviviale con Dio e con i fratelli. Ma dal fianco di Gesù, dopo il colpo di lancia del soldato, uscì non solo acqua, bensì anche sangue (Gv 19, 34; cfr 1 Gv 5, 6. 8). Gesù non ha solo parlato, non ci ha lasciato solo parole. Egli dona se stesso. Ci lava con la potenza sacra del suo sangue, cioè con il suo donarsi “sino alla fine”, sino alla Croce. La sua parola è più di un semplice parlare; è carne e sangue “per la vita del mondo” (Gv 6, 51).
Nei santi Sacramenti, il Signore sempre di nuovo s’inginocchia davanti ai nostri piedi e ci purifica. Preghiamolo, affinché dal bagno sacro del suo amore veniamo sempre più profondamente penetrati e così veramente purificati!
Se ascoltiamo il Vangelo con attenzione, possiamo scorgere nell’avvenimento della lavanda dei piedi due aspetti diversi. La lavanda che Gesù dona ai suoi discepoli è anzitutto semplicemente azione sua: il dono della purezza, della “capacità per Dio” offerto a loro. Ma il dono diventa poi un modello, il compito di fare la stessa cosa gli uni per gli altri.
I Padri hanno qualificato questa duplicità di aspetti della lavanda dei piedi con le parole sacramentum ed exemplum. Sacramentum significa in questo contesto non uno dei sette sacramenti, ma il mistero di Cristo nel suo insieme, dall’incarnazione fino alla croce e alla risurrezione: questo insieme diventa la forza risanatrice e santificatrice, la forza trasformatrice per gli uomini, diventa la nostra metabasis, la nostra trasformazione in una nuova forma di essere, nell’apertura per Dio e nella comunione con Lui.
Ma questo nuovo essere che Egli, senza nostro merito, semplicemente ci dà deve poi trasformarsi in noi nella dinamica di una nuova vita. L’insieme di dono ed esempio, che troviamo nella pericope della lavanda dei piedi, è caratteristico per la natura del cristianesimo in genere. Il cristianesimo, in rapporto col moralismo, è di più e una cosa diversa. All’inizio non sta il nostro fare, la nostra capacità morale. Cristianesimo è anzitutto dono: Dio si dona a noi – non dà qualcosa, ma se stesso. E questo avviene non solo all’inizio, nel momento della nostra conversione. Egli resta continuamente Colui che dona. Sempre di nuovo ci offre i suoi doni. Sempre ci precede. Per questo l’atto centrale dell’essere cristiani è l’Eucaristia: la gratitudine per essere stati gratificati, la gioia per la vita nuova che Egli ci dà.
Con ciò, tuttavia, non restiamo destinatari passivi della bontà divina. Dio ci gratifica come partner personali e vivi. L’amore donato è la dinamica dell’“amare insieme”, vuol essere in noi vita nuova a partire da Dio. Così comprendiamo la parola che, al termine del racconto della lavanda dei piedi, Gesù dice ai suoi discepoli e a tutti noi: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13, 34). Il “comandamento nuovo” non consiste in una norma nuova e difficile, che fino ad allora non esisteva. Il comandamento nuovo consiste nell’amare insieme con Colui che ci ha amati per primo.
Così dobbiamo comprendere anche il Discorso della montagna. Esso non significa che Gesù abbia allora dato precetti nuovi, che rappresentavano esigenze di un umanesimo più sublime di quello precedente. Il Discorso della montagna è un cammino di allenamento nell’immedesimarsi con i sentimenti di Cristo (cfr Fil 2, 5), un cammino di purificazione interiore che ci conduce a un vivere insieme con Lui. La cosa nuova è il dono che ci introduce nella mentalità di Cristo. Se consideriamo ciò, percepiamo quanto lontani siamo spesso con la nostra vita da questa novità del Nuovo Testamento; quanto poco diamo all’umanità l’esempio dell’amare in comunione col suo amore. Così le restiamo debitori della prova di credibilità della verità cristiana, che si dimostra nell’amore. Proprio per questo vogliamo tanto maggiormente pregare il Signore di renderci, mediante la sua purificazione, maturi per il nuovo comandamento.
Nel Vangelo della lavanda dei piedi il colloquio di Gesù con Pietro presenta ancora un altro particolare della prassi di vita cristiana, a cui vogliamo alla fine rivolgere la nostra attenzione.
In un primo momento, Pietro non aveva voluto lasciarsi lavare i piedi dal Signore: questo capovolgimento dell’ordine, che cioè il maestro – Gesù – lavasse i piedi, che il padrone assumesse il servizio dello schiavo, contrastava totalmente con il suo timor riverenziale verso Gesù, con il suo concetto del rapporto tra maestro e discepolo. “Non mi laverai mai i piedi”, dice a Gesù con la sua consueta passionalità (Gv 13, 8). È la stessa mentalità che, dopo la professione di fede in Gesù, Figlio di Dio, a Cesarea di Filippo, lo aveva spinto ad opporsi a Lui, quando aveva predetto la riprovazione e la croce: “Questo non ti accadrà mai!”, aveva dichiarato Pietro categoricamente (Mt 16, 22). Il suo concetto di Messia comportava un’immagine di maestà, di grandezza divina. Doveva apprendere sempre di nuovo che la grandezza di Dio è diversa dalla nostra idea di grandezza; che essa consiste proprio nel discendere, nell’umiltà del servizio, nella radicalità dell’amore fino alla totale auto-spoliazione. E anche noi dobbiamo apprenderlo sempre di nuovo, perché sistematicamente desideriamo un Dio del successo e non della Passione; perché non siamo in grado di accorgerci che il Pastore viene come Agnello che si dona e così ci conduce al pascolo giusto.
Quando il Signore dice a Pietro che senza la lavanda dei piedi egli non avrebbe potuto aver alcuna parte con Lui, Pietro subito chiede con impeto che gli siano lavati anche il capo e le mani. A ciò segue la parola misteriosa di Gesù: “Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi” (Gv 13, 10). Gesù allude a un bagno che i discepoli, secondo le prescrizioni rituali, avevano già fatto; per la partecipazione al convito occorreva ora soltanto la lavanda dei piedi. Ma naturalmente si nasconde in ciò un significato più profondo. A che cosa si allude? Non lo sappiamo con certezza. In ogni caso teniamo presente che la lavanda dei piedi, secondo il senso dell’intero capitolo, non indica un singolo specifico Sacramento, ma il sacramentum Christi nel suo insieme – il suo servizio di salvezza, la sua discesa fino alla croce, il suo amore sino alla fine, che ci purifica e ci rende capaci di Dio.
Qui, con la distinzione tra bagno e lavanda dei piedi, tuttavia, si rende inoltre percepibile un’allusione alla vita nella comunità dei discepoli, alla vita nella comunità della Chiesa – un’allusione che Giovanni forse vuole consapevolmente trasmettere alle comunità del suo tempo. Allora sembra chiaro che il bagno che ci purifica definitivamente e non deve essere ripetuto è il Battesimo – l’essere immersi nella morte e risurrezione di Cristo, un fatto che cambia la nostra vita profondamente, dandoci come una nuova identità che rimane, se non la gettiamo via come fece Giuda.
Ma anche nella permanenza di questa nuova identità, per la comunione conviviale con Gesù abbiamo bisogno della “lavanda dei piedi”. Di che cosa si tratta? Mi sembra che la Prima Lettera di san Giovanni ci dia la chiave per comprenderlo. Lì si legge: “Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa” (1Gv 1, 8s). Abbiamo bisogno della “lavanda dei piedi”, della lavanda dei peccati di ogni giorno, e per questo abbiamo bisogno della confessione dei peccati.
Come ciò si sia svolto precisamente nelle comunità giovannee, non lo sappiamo. Ma la direzione indicata dalla parola di Gesù a Pietro è ovvia: per essere capaci a partecipare alla comunità conviviale con Gesù Cristo dobbiamo essere sinceri. Dobbiamo riconoscere che anche nella nostra nuova identità di battezzati pecchiamo. Abbiamo bisogno della confessione come essa ha preso forma nel Sacramento della riconciliazione. In esso il Signore lava a noi sempre di nuovo i piedi sporchi e noi possiamo sederci a tavola con Lui.
Ma così assume un nuovo significato anche la parola, con cui il Signore allarga il sacramentum facendone l’exemplum, un dono, un servizio per il fratello: “Se dunque io, il Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri” (Gv 13, 14). Dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri nel quotidiano servizio vicendevole dell’amore. Ma dobbiamo lavarci i piedi anche nel senso che sempre di nuovo perdoniamo gli uni agli altri. Il debito che il Signore ci ha condonato è sempre infinitamente più grande di tutti i debiti che altri possono avere nei nostri confronti (cfr Mt 18, 21–35). A questo ci esorta il Giovedì Santo: non lasciare che il rancore verso l’altro diventi nel profondo un avvelenamento dell’anima. Ci esorta a purificare continuamente la nostra memoria, perdonandoci a vicenda di cuore, lavando i piedi gli uni degli altri, per poterci così recare insieme al convito di Dio.
Il Giovedì Santo è un giorno di gratitudine e di gioia per il grande dono dell’amore sino alla fine, che il Signore ci ha fatto. Vogliamo pregare il Signore in questa ora, affinché gratitudine e gioia diventino in noi la forza di amare insieme con il suo amore. Amen.
© Copyright 2008 — Libreria Editrice Vaticana
———-
Sandro Magister è stato firma storica del settimanale L’Espresso.
Questo è l’attuale indirizzo del suo blog Settimo Cielo, con gli ultimi articoli in lingua italiana: settimocielo.be
Ma di Settimo Cielo è consultabile anche l’intero archivio, anno per anno e in più lingue:
> 2025–2024-2023–2022-2021–2020-2019–2018-2017
Come pure l’indice completo del blog www.chiesa che l’ha preceduto:
> 2016–2015-2014–2013-2012–2011-2010–2009-2008–2007-2006–2005-2004–2003-2002
